Mito ed epica a Roma – Il poema di Roma: l’Eneide 3di4

La Sibilla mostra a Caronte il ramo d’oro
Sulle rive del fiume, si affolla la turba delle anime che non hanno ricevuto i riti della sepoltura e che sono costrette a vagare per un secolo prima di essere ammesse nell’oltretomba. Tra di essi si trovava anche Palinuro, cui non era stato consentito di fare ingresso nell’aldilà perché non gli erano stati resi gli onori della sepoltura: Enea promise che al suo ritorno avrebbe provveduto a celebrare il rito funebre.
Il nocchiere dei morti, Caronte, inizialmente si rifiutò di traghettare sulla sua barca il figlio di Anchise in quanto ancora appartenente al mondo dei vivi; si rassegnò a trasportarli solo quando la Sibilla mostrò un ramo d’oro, il simbolo chiave degli inferi.
Chiunque tu sia
che ti dirigi armato al nostro fiume, orsù,
di lì dimmi perché vieni e ferma il passo. Questo
è il luogo delle Ombre, del Sonno e della soporifera Notte;
non è permesso trasportare corpi viventi
sulla barca Stigia. Né in verità mi rallegrai
d’aver accolto sul lago l’Alcide che andava
né Teseo e Piritoo, benché fossero stati generati
da dei e invitti per la loro forza. Con la violenza
Ercole mise in catene il custode del Tartaro
e tremante lo trascinò via dal trono stesso del re;
questi tentarono di portar via dal talamo la regina di Dite.
VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 388-397
(traduzione di G. BONGHI)
Caronte condusse Enea e la Sibilla incolumi al di là del fiume, sul fango informe della palude stigia. I due mortali incontrarono quindi Cerbero, il cane a tre teste custode dell’Ade: la Sibilla riuscì ad ammansirlo gettandogli una focaccia soporifera.
L’enorme Cerbero col suo latrato da tre fauci
rintrona questi regni giacendo immane
davanti all’antro. La veggente, vedendo
ormai i suoi tre colli diventare irti di serpenti
gli getta una focaccia soporosa con miele
ed erbe affatturate. Quello, spalancando
con fame rabbiosa le tre gole l’afferra
e sdraiato per terra illanguidisce l’immane dorso
e smisurato si stende in tutto l’antro.
VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 417-423
(traduzione di G. BONGHI)
Lasciate le rive della palude. Enea e la Sibilla si inoltrarono nel regno “da cui non si può tornare”, scorgendo le anime degli infanti morti prematuramente; davanti a loro si ergeva Minosse, giudice dell’oltretomba assieme a Eaco e Radamanto.
Sta Minos ne l’entrata, e l’urna avanti
tien de’ lor nomi, e le lor vite esamina,
e le lor colpe; e quale è questa o quella,
tal le dà sito, e le rauna e parte.
Virgilio, Eneide, Libro VI, vv. 432-433
(traduzione di A. CARO)
Nei pressi si trovavano i Campi del Pianto, dove dimorano coloro i quali sono morti perché consunti da una passione amorosa, e i Campi degli Eroi, dove albergavano quanti erano valorosamente caduti in guerra. Enea scorse l’ombra di Didone, che al passaggio dell’eroe troiano si rifiutò di rivolgergli la parola.
E non lontano da lì, da tutte le parti a distesa,
ecco i Campi del Pianto: con questo nome li chiamano.
Qui quanti un duro amore consunse in crudele disfarsi
strade appartate nascondono e, intorno, protegge di mirti
una selva; le pene nemmeno in morte li lasciano.
È in questi luoghi che scorge Fedra e Procri e Erifìle
mesta, che mostra le piaghe inferte dal figlio crudele,
ed Evadne e Pasìfae; ad esse vanno compagne
Laodamìa e, giovinetto un tempo, Cèneo, ora femmina
e nell’antica figura per fato di nuovo mutato.
E la fenicia Didone, di fresca ferita, fra loro
nella gran selva vagava; e, come l’eroe dei Troiani
si trovò a lei vicino e lei riconobbe fra le ombre
scura, quale chi al primo iniziare del mese la luna
o vede sorgere o crede di aver fra le nubi intravista,
non trattenne le lacrime e con dolce amore le disse:
«Vera, o infelice Didone, era a me dunque giunta la voce
che tu eri morta, seguendo la sorte estrema col ferro?
Ahi, della morte ti fui causa io? Per le stelle, lo giuro,
per i sùperi e se una lealtà vale in fondo alla terra,
contro mia voglia, regina, dal tuo lido ho preso congedo.
Ma me i comandi divini, che ora qui a andare fra le ombre,
per luoghi squallidi e putridi e notte profonda mi forzano,
hanno spinto coi loro decreti; né avrei mai creduto
che ti avrei dato, partendo, un simile grande dolore.
Ferma il tuo passo, e non ti sottrarre al mio sguardo! Chi fuggi?
Questa è per fato l’ultima volta che posso parlarti».
Con tali detti Enea quell’animo ardente e dal torvo
sguardo voleva lenire, e lacrime intanto versava.
Lei, altrove rivolta, gli occhi fissava giù a terra,
né si smuoveva nel volto al discorso intrapreso più che se
fosse una statua di dura pietra o di roccia marpèsia.
E infine se ne andò via e piegò, rifugiandosi, ostile
nell’umbrifero bosco, dove lo sposo di un tempo
alle sue cure risponde, Sichèo, e ne ricambia l’amore.
Non di meno Enea, percosso da quel caso avverso,
lei, che va via, con le lacrime segue, lontano, e commisera.
VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 440-476
(traduzione a cura di S. CONTE)
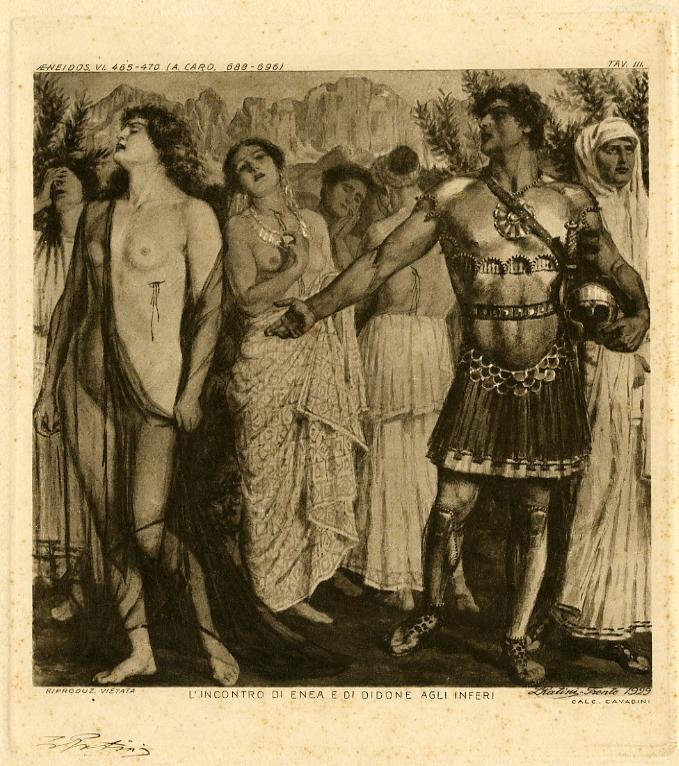
Enea incontra Didone negli Inferi
Di lì, Enea poté solamente scorgere il Tartaro, il tristo luogo (circondato dal fiume Flegetonte) dove scontano la loro pena gli empi e i malvagi.
Allora la veggente così cominciò a parlare:
“Glorioso capo dei Teucri, a nessuna anima pura
è lecito soffermarsi sulla soglia scellerata;
ma Ecate quando mi prepose ai boschi Averni,
ella stessa mi mostrò i castighi degli Dei
e mi condusse per tutti i luoghi.
Radamanto di Cnosso governa questi regni
tanto dolorosi, castiga, ascolta le colpe
e costringe a confessare le colpe commesse tra
i vivi che qualcuno, lieto dell’inutile frode,
rimandò di espiare oltre la morte lontana.
Subito dopo la vendicatrice Tisifone armata
di un flagello sferza oltraggiando i colpevoli
e agitando minacciosa i contorti serpenti
con la sinistra chiama la crudele schiera delle sorelle.
Allora finalmente si aprono le porte maledette
stridendo con orribile suono sul cardine.
Vedi quale custode siede nel vestibolo?
Quale figura è a guardia delle porte?
Più crudele di questa l’Idra immane
con cinquanta nere bocche spalancate
ha qui dentro la sua sede.
Poi il Tartaro stesso si apre come un precipizio
e si stende sotto l’oscurità per due volte tanto
quanto la vista del cielo si estende fino all’etereo Olimpo.
Qui l’antica prole della Terra, la gioventù dei Titani
abbattuti dal fulmine, si voltola nel basso profondo.
Qui vidi anche i gemelli Aloidi dall’immenso corpo
che tentarono di rovesciare colle loro mani
il grande cielo e di cacciare Giove dai regni superni.
Vidi anche Salmoneo che scontava pene crudeli
per aver imitato i fulmini di Giove e il tuono dell’Olimpo.
Questi, trascinato da quattro cavalli e agitando
una fiaccola andava trionfante fra i popoli Greci
e per le città in mezzo all’Elide e chiedeva per sé
l’onore riservato agli Dei: folle, che simulava i nembi
e l’inimitabile fulmine col bronzo e col galoppo
dei cavalli dalle unghie di corno.
Ma il padre onnipotente tra le dense nubi
scagliò un dardo, non come Salmoneo agitava
le fiaccole o le fiamme fumose d’una torcia,
e in un turbine immenso lo gettò a capofitto.
E così pure si poteva vedere Tizio figlio della Terra
madre di tutto, che si estende per nove iugeri interi
e un immane avvoltoio rodendo col becco adunco
il fegato immortale e le viscere feconde
di tormenti scava per il suo banchetto ed abita
nel profondo petto né viene concessa
un po’ di requie alle fibre che sempre ricrescono.
E dovrei ricordare anche i Lapiti, Issione e Piritoo
sui quali è sospesa una nera rupe che sta lì lì per cadere
e somiglia ad una che sta per cadere?
Splendono auree testate negli alti triclinii
festosi e vivande imbandite davanti agli occhi
con lusso regale; sta sdraiata la più vecchia delle Furie
lì vicino e impedisce di toccare le mense con le mani
e si leva agitando una fiaccola e urlando con voce tonante.
Qui si trovano coloro che odiarono i fratelli
mentre durava la vita o percossero il padre
o ordirono qualche frode a un protetto
o coloro che da soli guardarono ammassate
ricchezze e non le divisero coi loro parenti
(questa è la folla più grande),
e quelli che furono uccisi per adulterio
o seguirono empie armi o non esitarono
a tradire il giuramento fatto ai padroni:
rinchiusi qui aspettano la pena.
Non chiedere di sapere quale pena
o quale tipo di scelleratezza o destino
abbia sommerso questi uomini.
Alcuni rotolano un sasso immenso
e pendono legati ai raggi delle ruote;
siede e starà seduto in eterno l’infelice Teseo;
e lo sventurato Flegias ammonisce tutti
e testimonia ad alta voce nell’oscurità:
– Ammoniti dal mio esempio imparate
la giustizia e non disprezzate gli Dei -.
Questo per oro vendette la patria
ed impose un potente tiranno,
per denaro fissò le leggi e le abrogò;
quello penetrò nel talamo della figlia,
illecito imeneo;
tutti osarono commettere un esecrando
delitto e compirono il delitto osato.
Se avessi cento lingue e cento bocche
e una ferrea voce, non potrei descrivere
tutte le forme di delitti ed enumerare
tutti i nomi delle pene.
VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 562-627
(traduzione di G. BONGHI)
Ad Enea non venne concesso di poter entrare nel Tartaro, ma gli venne accordato di entrare nei Campi Elisi, dove scorrono il fiume Lete e le sorgenti dell’Eridano (antico nome del Po).
Qui se ne stan le fortunate genti,
parte in su’ prati e parte in su l’arena
scorrendo, lotteggiando, e vari giuochi
di piacevol contesa esercitando;
parte in musiche, in feste, in balli, in suoni
se ne van diportando, ed han con essi
il tracio Orfeo, ch’in lungo abito e sacro
or con le dita, ed or col plettro eburno,
sette nervi diversi insieme uniti,
tragge del muto legno umani accenti.
Virgilio, Eneide, Libro VI, vv. 637-647
(traduzione di A. CARO)
Enea poté incontrare il padre Anchise, che gli mostrò l’Eliso e le anime di coloro i quali, bevuta l’acqua del fiume Lete (che provoca l’oblio), si incarneranno in nuovi corpi e vivranno un’altra vita: tra queste, Enea riuscì a scorgere quelle dei suoi discendenti, che daranno origine alla stirpe dei Romani.
Ecco, ora ti spiegherò con le parole
quale gloria raggiungerà in futuro
la prole di Dardano, quali discendenti
rimarranno della gente italica, anime illustri
destinate a portare il nostro nome
e ti ammaestrerò sui tuoi destini.
Vedi quel giovane che si appoggia
a una semplice asta, occupa per sorte
i luoghi più vicini alla luce, per primo
sorgerà all’aria eterea misto di Italo sangue,
Silvio, nome Albano, tua postuma prole
che nato tardi a te ormai vecchio la sposa
Lavinia alleverà nelle selve come re e padre
di re da cui la nostra stirpe dominerà Alba Longa.
Quello vicino a lui è Proca, gloria del popolo Troiano,
e Capi e Numitore e Silvio Enea
che porterà il tuo stesso nome, parimenti egregio
nella pietà e nelle armi se mai avrà ottenuto
di regnare su Alba. Che giovani!
Guarda che grande forza dimostrano!
E portano le tempie ombreggiate di quercia civile.
Questi ti costruiranno Nomento e Gabii
e la città di Fidene, questi altri sui monti
le rocche Collatine, Pomezia, la Fortezza di Inuo,
Bola e Cora. Questi saranno allora i nomi,
mentre ora sono terre senza nome.
Ecco che al suo avo si aggiungerà come compagno
Romolo figlio di Marte, che una madre Troiana
del sangue di Assaraco alleverà. Vedi come si erge
il duplice cimiero sul capo e il padre stesso lo fregia
dell’onore proprio degli Dei? Ecco, o figlio, sotto
i suoi auspici la Roma gloriosa eguaglierà
il suo impero alle terre e il suo spirito all’Olimpo.
Essa sola circonderà con mura sette colli,
fortunata d’una stirpe di eroi; come la madre
Berecinzia con la corona turrita è trasportata
sul cocchio per le città della Frigia lieta
per la sua prole divina, abbracciando cento nipoti,
tutti abitatori del cielo, tutti occupanti alti posti elevati.
Ora volgi qua i tuoi occhi, guarda questa gente
e i tuoi Romani. Qui Cesare e tutta la discendenza
di Iulo che verrà sotto l’ampia volta del cielo;
questo è l’uomo. Questo è colui che molto spesso
ti senti promettere, Cesare Augusto, figlio del Divo,
che di nuovo riporterà nel Lazio il secolo d’oro
per i campi un tempo dominati da Saturno
ed estenderà il suo dominio sui Garamanti
e sugli Indi, sulle terre che si estendono
oltre le vie dell’anno e del sole, fin dove Atlante
reggitore del cielo regge sulle spalle la volta celeste
cosparsa di stelle ardenti. Già ora per il suo arrivo
rabbrividiscono i regni del Caspio e la terra Meotica
per i responsi degli Dei e si turbano le trepide foci
del Nilo dalle sette ramificazioni.
Nemmeno Ercole discendente d’Alceo
percorse tanta vastità di terre,
sebbene abbia trafitto la cerva dai piedi
di bronzo e avesse reso sicuri i boschi d’Erimanto
e fatto tremare col suo arco l’Idra di Lerna
né Libero che vittorioso guida il carro con redini
intrecciate di pampini, spingendo le tigri giù
dall’alta vetta del Niso. E ancora dubitiamo
di estendere il dominio col valore o la paura
ci impedisce di fermarci nella terra Ausonia?
Chi è quell’alto eroe incoronato di olivo
che porta gli arredi sacri? Riconosco
i capelli e il mento canuto del re romano
che fonderà con le leggi la nuova città,
chiamato dalla piccola Curi e da una povera
terra a un grande potere. A lui succederà poi
Tullo Ostilio che infrangerà la quiete della patria
e spingerà alle armi gli uomini tranquilli e le schiere
già disavvezze ai trionfi. Lo segue da vicino
il troppo presuntuoso Anco che anche ora qui
si compiace del favore popolare. Vuoi vedere
i re Tarquini e l’anima superba del vendicatore
Bruto e i fasci recuperati? Questi per primo
riceverà il potere di console e le crudeli scuri
e, padre, chiamerà al supplizio i figli in difesa
della bella libertà, sventurato, comunque i posteri
giudicheranno quei fatti: vincerà l’amor di patria
e l’immensa brama di gloria. Guarda inoltre
laggiù i Decii e i Drusi e Torquato inesorabile
con la scure e Camillo che riportò le insegne.
VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 756-825
(traduzione di G. BONGHI)
Enea e Deifobe giunsero quindi alle porte del Sonno, da cui escono i sogni; di esse una si dice sia fatta di corno, attraverso la quale escono i sogni veritieri; l’altra è rilucente e fatta di candido avorio, ma attraverso di essa passano i sogni fallaci. Anchise accompagnò il figlio insieme alla Sibilla e li fece uscire dalla porta d’avorio; Enea riprese quindi il suo viaggio, che l’avrebbe poi condotto sulle rive del Lazio a fondare una nuova patria per i Troiani.

Enea e la Sibilla nell’Ade
I Troiani, dopo aver seppellito Caieta, la nutrice di Enea, nella terra che prenderà il suo nome (Gaeta), costeggiarono la terra di Circe e giunsero infine alla foce del fiume Albula: dopo aver tratto in secco le navi, Enea ed i suoi compagni prepararono il desinare e, presi dalla fame, cominciarono a divorare le mense (in epoca antica, in luogo dei piatti venivamo spesso utilizzate delle focacce di grano duro…): si avverò in tal modo la profezia di Celeno l’Arpia.
Il figlio di Anchise decise di inviare un araldo presso il re del luogo, Latino, che accolse con favore gli stranieri: suo padre, il dio italico Fauno, gli aveva infatti preannunciato che l’unione di uno straniero con sua figlia Lavinia avrebbe generato una stirpe eroica e gloriosa: per questo motivo il re aveva in precedenza rifiutato di concedere Lavinia in moglie al giovane sovrano dei Rutuli, il bellicoso Turno.
La prospettiva di un matrimonio tra Enea e Lavina non piacque alla dea Giunone (che persisteva nel suo feroce odio nei confronti di Troia e dei suoi discendenti), la quale riuscì a fomentare l’odio delle popolazioni locali nei confronti degli stranieri: ella inviò la furia Aletto dalla regina Amata (moglie di Latino) e poi dallo stesso Turno.
La regina, eccitata da un furore, inveì contro il marito e si mise poi a correre come una baccante per le vie della città, trascinandosi dietro altre donne e la stessa figlia Lavinia. Turno ruppe i patti con il re Latino e, spinto da un atroce desiderio di vendetta, chiamò a raccolta suoi i Rutuli.
Un banale incidente (Julo per errore ferì a morte un cervo che i pastori del re Latino avevano addomesticato e curato) fece scoppiare una rissa, con morti e feriti da entrambe le parti. Amata e Turno ne approfittarono per indurre Latino a dichiarare guerra ad Enea. Poiché il re indugiava, Giunone stessa spalancò le porte del tempio di Giano, la cui apertura precedeva le dichiarazioni di guerra.
Il sovrano dei Rutuli riuscì a portare dalla sua parte una coalizione che comprendeva molti degli Italici, come l’etrusco Mesenzio, bestemmiatore degli Dei, e il figlio Lauso; Aventino, figlio di Ercole; Messapo, figlio di Nettuno, che guidava i Fescennini e gli Equi; Clauso, con la gente della Sabina; Umbrone con i Marsi; Ebalo con i Campani; Virbio, figlio di Ippolito e nipote di Teseo[1]; Camilla, vergine guerriera, figlia del re dei Volsci. Turno inviò anche un’ambasciata in Puglia, dove l’eroe greco Diomede aveva fondato numerose città.
Durante la notte, ad Enea apparve in sogno il dio Tiberino, che gli consigliò di trovare alleati a Pallanteo, una città fondata dal greco Evandro (originario dell’Arcadia); al suo risveglio, l’eroe preparò due biremi per salire il corso del fiume, quand’ecco apparve una candida scrofa con trenta porcellini: il segno predetto da Eleno. Subito Enea immolò gli animali ai numi ed iniziò la sua navigazione.
Giunti a Pallanteo, una piccola città sul colle Palatino, i Troiani tesero un ramo d’olivo in segno di pace. Evandro, che un tempo in Arcadia aveva ospitato Anchise, accolse con benevolenza Enea e, dopo averlo ascoltato, non solo promise sostegno nella guerra contro i Latini ma gli consigliò di trovare alleanze presso gli Etruschi.
Poiché gli Arcadi stavano celebrando un sacrificio in onore di Ercole, Evandro spiegò a Enea le origini di quel culto e mostrò all’eroe i luoghi dove un giorno sarebbe sorta la città di Roma.
Quando fu tolta la fame e placato il desiderio del cibo,
il re Evandro dice: «Non fu una vana superstizione,
ignara degli antichi Dei, ad imporci queste cerimonie,
questo banchetto rituale, quest’ara di tanto nume:
salvàti da crudeli pericoli, ospite troiano,
rendiamo e rinnoviamo le dovute onoranze.
Guarda prima la rupe sospesa su massi, guarda
quei macigni lontano spaccati, la deserta casa che si erge
sul fianco del monte, e come quei sassi trascinarono
un’enorme rovina.
Qui vi fu una spelonca, nascosta in un vasto recesso,
che l’orribile aspetto del bestiale Caco occupava,
inaccessibile ai raggi del sole; la terra era sempre
tiepida di strage recente, e confitte alle superbe porte
pendevano teste d’uomo pallide di sinistra putredine.
Padre di questo mostro era Vulcano: eruttando dalla bocca
i suoi neri fuochi, avanzava con vasta mole.
Il tempo apportò a noi imploranti l’aiuto
e l’arrivo del Dio. Supremo vendicatore,
superbo della morte e delle spoglie di Gerione dai tre corpi,
L’Alcide veniva, e di qui vittorioso spingeva
enormi tori; L’armento teneva la valle e il fiume.
Ma il cuore selvaggio e furioso di Caco, affinché non vi fosse
nessun delitto e inganno inosato o intentato,
rubò dalle stalle quattro tori di splendido
corpo, e altrettante giovenche di straordinaria bellezza;
perché non vi fossero orme diritte di piedi,
li trascinò per la coda nella spelonca, e con tracce
rovesciate li occultò predati nell’oscura roccia:
a chiunque cercasse, nessuna impronta indicava l’antro.
Frattanto, poiché Ercole ormai muoveva
dalle stalle gli armenti saziati e preparava la partenza,
le mucche nell’allontanarsi muggirono, e tutto il bosco
si riempì di lamenti: con clamore lasciavano i colli.
Una delle giovenche rispose al richiamo, e nel vasto antro
muggì e pur custodita ingannò la speranza di Caco.
Allora la collera dell’Alcide riarse di furia
e di nera bile: impugna le armi e la clava nodosa,
e si dirige di corsa alle alture dell’aereo monte.
Allora per la prima volta i nostri occhi videro Caco
atterrito e sconvolto; subito fugge più veloce dell’Euro,
e si dirige alla spelonca; lo spavento aggiunse ali ai piedi.
Appena si rinchiuse, rotte le catene, staccò
l’enorme pietra sospesa col ferro e con l’arte
paterna e fece del masso difesa e puntello alla porta;
ecco furente nell’animo giungeva il Tirinzio
esplorando ogni via d’accesso e volgeva lo sguardo,
in qua e in là digrignando i denti. Tre volte ardente d’ira
percorse l’intero Aventino; tre volte squassò invano
le soglie pietrose, e stanco sedette nella valle.
Vi era una rupe aguzza, erta sul dorso della spelonca,
mozze dovunque le rocce, altissima a vedersi,
opportuna dimora a nidi di sinistri uccelli.
Come inclinata incombeva dal giogo sul fiume
a sinistra, egli verso destra forzandovi contro la scuote,
la sradica, la svelle dalla base; poi all’improvviso
la spinge; all’urto rimbomba l’altissimo etere,
sobbalzano le rive e rifluisce atterrito il fiume.
Appare la grotta e l’immensa reggia scoperchiata
di Caco, e s’aprirono le profonde, tenebrose caverne:
come se una forza spalancasse disserrando le profonde
sedi infernali e schiudesse i pallidi regni
invisi agli dei, e da sopra si vedesse l’immenso
baratro, e le ombre trepidassero per il lume che irrompe.
Dunque, còlto all’improvviso dalla luce inattesa,
e chiuso nella cava roccia e ruggente più del consueto,
dall’alto lo preme l’Alcide con dardi, e ricorre a tutte
le armi, e incalza con tronchi e con vasti macigni.
Quello, poiché non gli resta nessuno scampo al pericolo,
vomita dalle fauci (mirabile a dirsi) un’immensa
fumata e avvolge la casa in una cieca caligine,
togliendo la vista a chi guardi, e agglomera nell’antro
una notte fumosa, con tenebre miste a fuoco.
L’Alcide furioso non sopportò, e si gettò a precipizio
nel fuoco con un balzo, per dove il densissimo fumo
volge un’onda, e l’immensa grotta fluttua di fosca nebbia.
Qui, avvinghiatolo in un nodo, afferra Caco che emette
nelle tenebre vani incendi, e serrando lo soffoca
facendogli uscire gli occhi e seccare la gola di sangue.
Subito si apre la buia casa, rovesciate le porte,
e le vacche rubate e la preda negata con spergiuri
si mostrano al cielo; e l’orrendo cadavere è tratto
fuori per i piedi. I cuori non possono saziarsi
guardando i terribili occhi, il volto e il petto villoso
di setole della mezza belva e le fiamme estinte nelle fauci.
Da allora si celebra il rito, e i posteri lieti
ricordarono il giorno: Potizio ne fu promemore
e la casa Pinaria custode del culto di Ercole.
Egli pose nel bosco quest’ara, che Massima sempre
sarà detta da noi, e sarà Massima sempre.
Perciò, avanti, o giovani, nel culto di tali glorie
cingete la chioma di fronde e porgete i calici con la destra
e invocate il comune Dio e date vini col cuore.
Disse, e con ombra erculea il pioppo bicolore
velò le chiome e pendette intrecciato di foglie,
e la sacra coppa empì le destre. Subito tutti
libano lieti sulla mensa e pregano gli Dei.
VIRGILIO, Eneide, Libro VIII, vv. 184-279
(traduzione di L. CANALI)
Enea quindi si recò presso gli Etruschi a cercare alleati; in un momento di breve riposo, egli venne raggiunto dalla madre Venere, che gli consegnò le splendide armi forgiate da Vulcano. Mirabile la descrizione dello scudo, dove erano stati raffigurati i più grandi eventi ed i personaggi più illustri della Roma futura.
Ma tra i veli del cielo Venere bella
veniva con i doni e appena vide il figlio
appartato in una valle solitaria
presso il freddo fiume, si offrì
con tali parole: «Ecco i promessi doni,
dovuti all’arte del mio sposo, onde potrai
senz’altro, figliolo mio, chiamare a prova
i Laurenti superbi e il fiero Turno».
Disse e abbracciò il figlio; depose
le armi raggianti dinanzi a una quercia.
Egli, lieto del dono divino,
volge lo sguardo a ciascuna
delle armi, le rimira, agita tra le mani
il terribile elmo piumato
e la spada da dove esce fiamma
e morte, la corazza in saldo bronzo
vasta, sanguigna, come glauca nube
che si accende del sole e da lontano splende;
quindi i lisci schinieri di puro
oro e di elettro, l’asta e l’ultima
inenarrabile meraviglia dello scudo.
Il Dio del fuoco, conscio dei vaticini,
presagendo l’avvenire, vi aveva
rappresentato la storia d’Italia ed i trionfi romani;
la lunga discendenza di Ascanio
e in ordine le guerre combattute.
Aveva posto nel verde antro di Marte
una lupa sgravata, distesa per terra,
e alle poppe due pargoli gemelli
scherzare e suggere la madre
impavidi; ella, ripiegando molle la testa,
a vicenda tutti e due li leccava
con la lingua e li allisciava.
Aveva quindi aggiunto non lontano Roma
e le Sabine rapite ad arbitrio
dal teatro gremito nel grande Circo;
per cui era nata nuova guerra per i Romulidi
con il vecchio Tazio e la severa Curi.
Ma poi gli stessi re, riposte le offese,
dritti in armi con le tazze in mano
stavano davanti all’ara di Giove e, uccisa
una scrofa, stringevano alleanza.
Qui presso le rapide quadrighe
avevano squartato Mezio Fufezio (e tu,
Albano, dovevi rimanere fedele alla parola!)
e Tullo lacerava le viscere del falso;
roridi sanguinavano i virgulti.
E Porsenna ingiungeva di ricevere
lo scacciato Tarquinio e stringeva la città
di aspro assedio; pronti alle armi
correvano gli Eneadi per la libertà.
Irato lo vedevi e minaccioso
perché Coclite osava tagliare il ponte
e, rotti i ceppi, Clelia attraversava il fiume.
Alla sommità della rupe Tarpea stava
Manlio custode avanti al tempio e presidiava
l’alto Campidoglio; la reggia appariva ancora
ruvida della paglia romulea.
Pur qui starnazzando l’oca argentea
per i portici dorati denunciava
i Galli apparsi al limitare: i Galli
su per i cespugli occupavano la rocca,
tra le ombre e il dono della notte opaca.
Avevano capelli e vesti d’oro,
i mantelli screziati rilucevano,
i bianchi colli cingevano collane d’oro;
ognuno vibrava due giavellotti alpini,
adombrando la persona con lunghi scudi.
Aveva scolpito le danze dei Salii
e i nudi Luperci, i lanosi pennacchi
e gli scudi che piovono dal cielo:
le pie matrone sugli agiati cocchi
muovevano per la città i devoti riti.
Anche aggiunge da un lato le tartaree
sedi, i cupi vestiboli di Dite,
i castighi delle colpe e te,
Catilina, sospeso su un minaccioso
scoglio e tremante alla vista delle Furie:
da una parte i buoni e sopra di loro Catone.
Ampia in mezzo correva l’immagine
del gonfio mare in oro, ma l’azzurro
spumeggiava di candidi flutti:
in cerchio, intorno, nitidi e d’argento,
i delfini radevano l’ampiezza del mare
e solcavano i marosi con le code.
Avresti visto in quel mar flotte di bronzo,
la battaglia di Azio e Leucade fremere
tutto per la battaglia e lustrare d’oro i flutti.
Da una parte Augusto Cesare, alto
sull’alta poppa, guida gli Italici
alla battaglia, con i padri, il popolo, i Penati
e i grandi Dei: dalle superbe tempie
gli irradiano due fiamme e sul suo capo
brilla nello sguardo la paterna stella.
Dall’altra Agrippa con il favore dei venti
e degli Dei che guida eccelso i suoi:
la corona rostrata, insegna di guerra altera,
splende sulla sua fronte.
Dall’altra parte Antonio con la potenza
barbarica e le varie armi torna
vincitore dall’Aurora e dal Mar Rosso,
porta con sé l’Egitto, le forze
d’oriente e la remota Battra; lo
accompagna l’onta della moglie egiziana.
Tutti all’urto precipitano, tutto
il mare spumeggia sconvolto
dai remi e dai rostri tridentati.
Tendono verso l’alto, e crederesti
che le Cicladi divelte stiano nuotando,
che i monti urtino i grandi monti, tanta
mole si avanza di turrite prore.
Gli infiammati malleoli con la mano,
il volante ferro con le frombole
si spargono: già la faccia di Nettuno
diventa rossa. In mezzo appare la regina
che chiama le torme con il patrio sistro
né ancor si vedono i due serpenti alle spalle.
Gli Dei mostruosi di ogni gente
ed il latrante Anubi stanno in armi
contro Nettuno, Venere e Minerva.
Nel cuore della mischia infuria Marte,
scolpito nel ferro, e le sinistre Furie
per l’aria, accorre felice la Discordia
con il manto squarciato, la segue
con la sua frusta sanguinosa Bellona.
Fisso a guardare Apollo d’Azio tendeva
l’arco dall’alto: per tale terrore tutto
l’Egitto e gli Indi, gli Arabi, i Sabei,
tutti quanti voltavano le spalle.
Si vedeva la regina invocare
i venti, distendere le vele
abbandonare le gómene lente.
Il Dio del fuoco l’aveva raffigurata
pallida tra le stragi per la
morte imminente, portata
dalle onde e dal vento di Iapigia;
davanti a lei il gigantesco Nilo,
addolorato apriva i seni
dell’ampia veste, con quella chiamando
nel suo grembo inesplorato i vinti.
Ma Cesare, con triplice trionfo
entrando nelle mura romane, consacrava
ai Numi italici un voto immortale:
trecento grandi templi per la città.
Di tripudio fremevano le vie,
di festa e di plauso: le madri a schiera
in ogni tempio; e santuari e il suolo coperto
di vittime immolate davanti alle are.
Augusto, sedendo sulla nivea soglia
del biondo Febo, i doni delle genti
assegna e appende alle superbe porte:
vanno i popoli vinti in lunga fila,
diversi di lingue, di vesti
e di armi. Qui la stirpe dei Numidi
e i discinti Afri il divo fabbro pose,
qui i Lèlegi e i Cari e i saettanti
Geloni: ormai con più sommesso flutto
andava l’Eufrate, i Mòrini remoti,
il Reno bicorne e gli indomati
Daghi, l’Arasse che sdegna i ponti.
Questo sullo scudo di Vulcano, materno
dono, Enea contempla e, delle cose ignaro,
dell’immagine gode, alzando sulla spalla
la fama e il fato dei nipoti.
VIRGILIO, Eneide, Libro VIII, vv. 608-731
(liberamente tratto dalla traduzione di G. ALBINI)








Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.